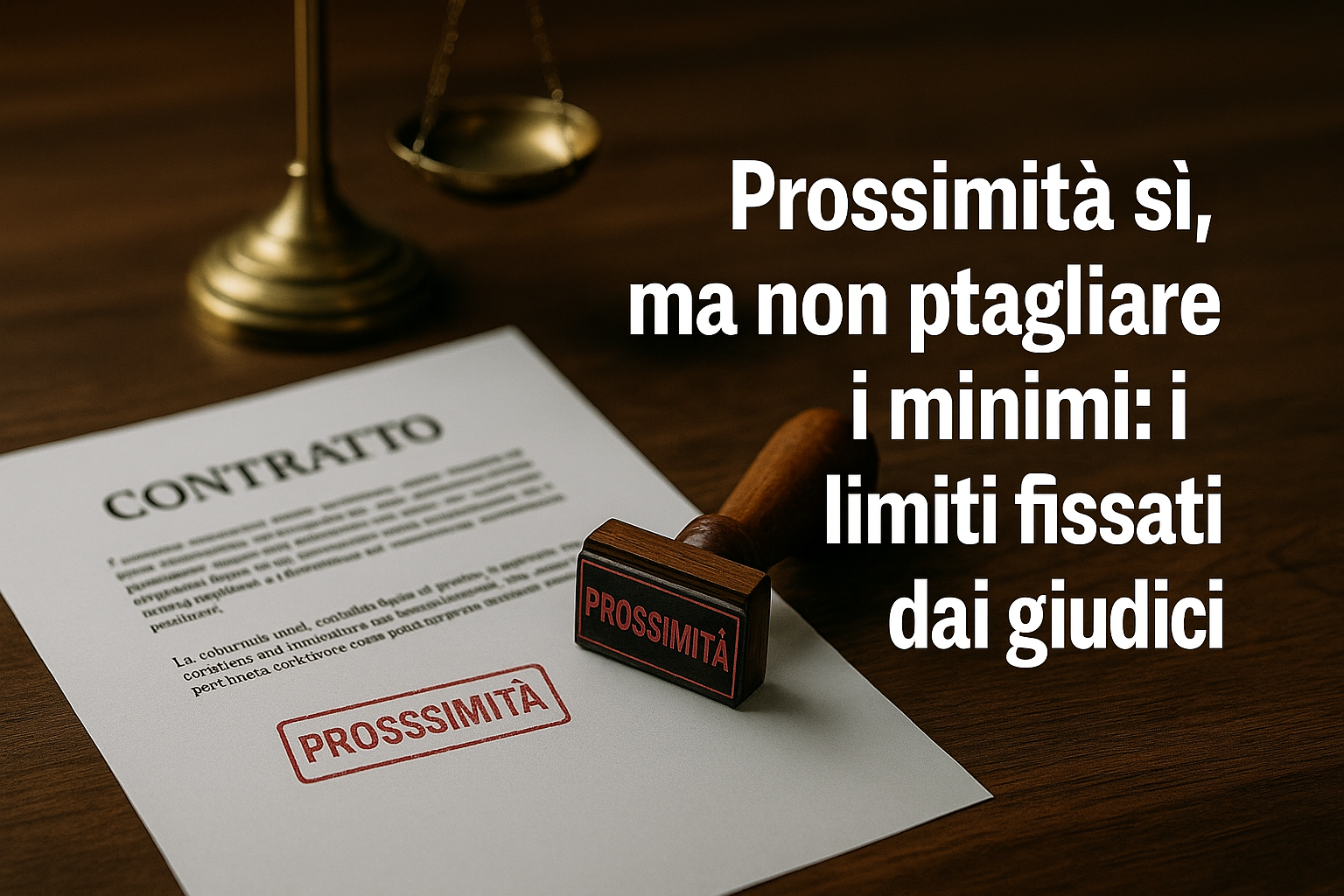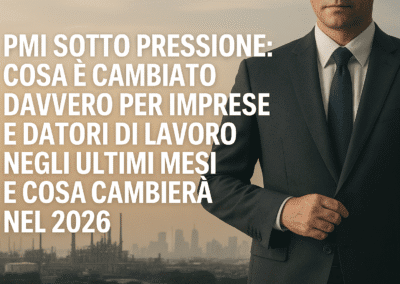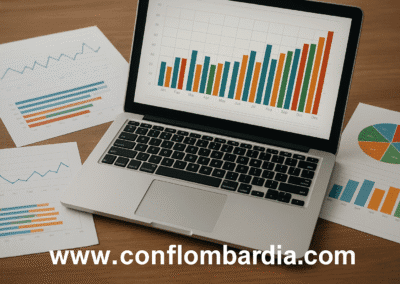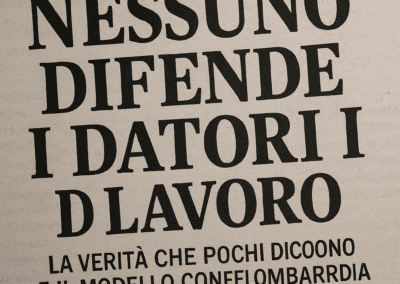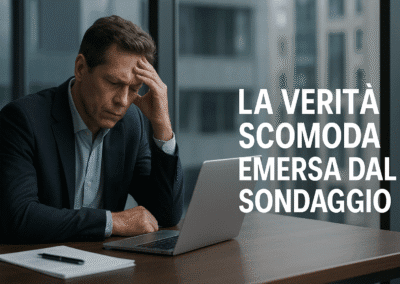Il senso originario della prossimità
Quando nel 2011 il legislatore introdusse l’art. 8 del D.L. 138, convertito nella L. 148/2011, il mondo del lavoro accolse l’istituto degli accordi di prossimità come una svolta. L’obiettivo era chiaro: permettere ad aziende e territori di adattare regole e modelli organizzativi alle specificità locali, senza essere ingabbiati da schemi rigidi. Era l’epoca della crisi economica globale, e la flessibilità era vista come la chiave per preservare posti di lavoro e competitività. Ma col passare degli anni, la prossimità ha subito una torsione: da strumento di innovazione è diventata, in molti casi, un grimaldello per comprimere i diritti. Proprio su questo si è concentrata la recente giurisprudenza, culminata con la Cassazione, ordinanza 19467/2025, che ha rimesso ordine: sì alla prossimità, ma non per abbassare i minimi retributivi e contributivi.
Cassazione 19467/2025: lo scudo dei minimi
La pronuncia del gennaio 2025 ha chiarito un punto che sembrava ancora controverso: nessun accordo di prossimità può legittimare una deroga in pejus ai minimi retributivi fissati dai CCNL comparativamente più rappresentativi. Il principio è semplice ma potente: la contrattazione collettiva territoriale o aziendale può incidere su organizzazione, orari, turni, welfare, premi di produttività, ma non può toccare il cuore della paga base. La Corte ha richiamato non solo l’art. 8 del D.L. 138/2011, ma anche l’art. 36 della Costituzione, che sancisce l’indisponibilità della retribuzione sufficiente. Di fatto, la Cassazione ha posto un limite invalicabile: la prossimità è un’opportunità per innovare, non un lasciapassare per tagliare stipendi.
Le altre pronunce confermative
La 19467/2025 non è un caso isolato. Già nel 2023 e nel 2024, la giurisprudenza aveva iniziato a circoscrivere i confini dell’istituto. Tribunali di Milano e Bologna avevano dichiarato illegittimi accordi aziendali che fissavano retribuzioni inferiori ai minimi del CCNL di categoria. Nel 2024, la Cassazione con la sentenza n. 3353 aveva precisato che la prossimità può essere valida solo se “proporzionata e ragionevole” e finalizzata a salvaguardare occupazione e produttività. La 19467/2025 ha completato il percorso, stabilendo un principio unificante: la prossimità è legittima, ma non può scardinare i minimi tabellari. La giurisprudenza sta dunque restituendo all’istituto la sua funzione originaria, sottraendolo agli abusi.
Le implicazioni per le imprese
Per le aziende, questo significa ridefinire il modo di concepire gli accordi di prossimità. Non più scorciatoie per ridurre il costo del lavoro, ma strumenti per migliorare l’organizzazione interna, la produttività e il benessere dei dipendenti. È possibile, ad esempio, concordare turni più flessibili, modelli di lavoro agile, strumenti di welfare personalizzati, sistemi di formazione continua. Ma se si tenta di toccare il minimo contrattuale o contributivo, l’accordo cade nel nulla e l’impresa si espone a sanzioni. L’impatto è forte soprattutto in settori come vigilanza, logistica e ristorazione, dove la prossimità era stata usata per comprimere salari. Le aziende dovranno cambiare approccio, trasformando la prossimità in leva di competitività, non di dumping.
Il ruolo dei sindacati e la rappresentatività
Altro punto chiave emerso dalla giurisprudenza riguarda la legittimità dei soggetti firmatari. Gli accordi di prossimità hanno valore solo se sottoscritti da organizzazioni sindacali e datoriali “comparativamente più rappresentative”. È un concetto che la Cassazione ha ribadito con forza: le intese firmate da sigle marginali non hanno efficacia vincolante. Questo criterio rafforza il ruolo dei sindacati confederali e delle associazioni datoriali più solide, restituendo al sistema contrattuale una gerarchia che negli anni era stata minata dalla proliferazione di contratti pirata. L’incrocio tra dati CNEL e flussi UNIEMENS diventa qui decisivo per smascherare intese spurie: se un accordo non ha reale applicazione, la sua validità viene automaticamente ridimensionata.
Scenari futuri: dal dumping all’innovazione
La prossimità del futuro non sarà più sinonimo di taglio, ma di innovazione. Le aziende che sapranno utilizzarla correttamente potranno introdurre modelli organizzativi più agili, rafforzare il welfare aziendale, migliorare la formazione e incentivare la produttività. È plausibile che nei prossimi anni la giurisprudenza consolidi ulteriormente questa linea, legando la validità degli accordi di prossimità alla capacità di generare benefici concreti per i lavoratori e per il sistema produttivo. Chi invece tenterà ancora di usarli come arma di dumping si troverà di fronte a un muro invalicabile: l’art. 36 Cost. e le soglie INPS. In questo senso, la prossimità rappresenta non un pericolo, ma una straordinaria opportunità per chi la sa maneggiare con intelligenza.
La bussola di CONFLOMBARDIA
Il messaggio ai nostri imprenditori è chiaro: la prossimità non è morta, ma è cambiata. Non serve più a comprimere i costi, serve a costruire valore. CONFLOMBARDIA è pronta a guidare le aziende in questo percorso con consulenze mirate, modelli di accordo conformi alla giurisprudenza e strumenti di analisi preventiva. Con l’Audit Minimi & CCNL supportiamo le imprese nel verificare i contratti applicati, controllare i flussi UNIEMENS e impostare accordi che rispettino la legge e valorizzino la produttività. Non è solo compliance: è strategia di crescita. Perché, come sempre, il nostro motto resta la bussola: “No mordi e fuggi, ma segui e servi.”